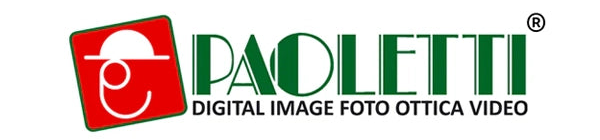La presente mostra, tratta dal libro fotografico “Flagelli d’Italia: memorie di una civilizzazione selvaggia” di recente pubblicazione, si pone l'obiettivo di far riflettere lo spettatore circa gli effetti dell’antropizzazione e delle attività umane sul clima e i suoi equilibri, ma altresì più in generale, si ripromette di porre interrogativi circa il rapporto che l'uomo ha con l'ecosistema.
Fin dagli albori della sua storia l'uomo ha sempre cercato di comprendere l’ambiente che lo circondava, ricavandone leggi e formule di cui abbisognava per la sua stessa sopravvivenza. Ha sempre "manipolato" le risorse che l'ambiente gli offriva, solitamente avendo però di questa "natura" e parimenti di questa "madre Terra" venerazione, adorazione e rispetto quale madre benevola, nutrice dispensatrice di frutti, di doni e di vita. Nella cultura occidentale tutto ciò è durato perlomeno fino al XVI e XVII secolo, quando con l'avvento della filosofia dell'Umanesimo prima e con la Rivoluzione Scientifica dopo, in un'epoca segnata altresì da conquiste tecno-scientifiche, dalla prima industrializzazione moderna e quindi dalla relativa ascesa del capitalismo, il rapporto dell'uomo con l'ecosistema e lo stesso concetto di "natura" è radicalmente cambiato, spostandosi sempre più da una concezione se vogliamo romantica a una di vero e proprio "dominio", verso un terreno di conquista e di appropriazione, verso quel "regno dell'umano" come affermava Bacone. Un modello di pensare le cose, una filosofia in cui l'uomo è posto sempre al centro di tutto, al vertice della piramide, quale principale attore e protagonista in un pianeta, i cui beni venivano via via sempre più considerati come mere risorse da sfruttare. Dimenticando, opprimendo, ostacolando i vari meccanismi che regolano clima, ambiente, e con essi tutto il resto del vivente. Opprimendo il "bios" come fosse proprietà esclusiva dell'uomo. Da questa concezione antropocentrica si è andata delineando l'esigenza di costruire un ordine sempre più dualistico, rigidamente dualistico, separando concetti quali uomo e animale, natura e cultura, ambiente urbano e ambiente rurale, selva e civiltà, soffocando in modo esiziale così ogni contatto fra le due sfere, ogni reciproca interferenza ed interconnessione. Si tratta di un ordine che suona come opprimente, asfissiante oltre che astratto, e per sua natura mutevole a seconda delle ideologie o posizioni culturali dominanti, tanto che le linee di confine tra i due domini, il "naturale" ed il "culturale" ad esempio, un tempo ritenute nette, precise e inequivocabili, sono oggi molto più sfumate e incerte (come notava Lévi-Strauss nella seconda edizione delle Structures 1967). Pensiamo ad esempio a una categoria come il linguaggio e il simbolismo: un tempo erano creduti appannaggio della sola sfera umana.
È proprio da questo concetto oppressivo e se vogliamo autoritario, arbitrario, di "ordine" che prende forma la prima sezione della mostra, in cui viene espressa l'astrazione ed insieme l'impellenza da parte dell'uomo, di creare artificialmente una distinzione, una scissione e conseguentemente una sottostante gerarchizzazione delle cose del mondo, attraverso immagini ed insieme concetti esemplari quali "la frontiera", "l'argine", "gli alberi da abbattere" separati dal nastro dei "lavori in corso" dalla "città degli uomini" rappresentata da un'architettura a forma di piramide costitutiva di una fontana pubblica, e ancora le architettura della stazione AV Mediopadana di Calatrava a Reggio Emilia che, come molte opere artistiche e costruzioni umane, imitano e s'ispirano o sono inspirate proprio dalla natura. Per quanto riguarda l'immagine che apre la sezione, la “frontiera”, essa rimanda ad un immaginario bellico, dal latino "frons" che significa "fronte". Etimologicamente era infatti il luogo dove ci si incontrava venendo da due direzioni opposte. Frontiera dunque, la linea immaginaria spesso tracciata in geografia politica per separare due territori, due comunità. Generalizzando, potremmo dire anche due entità astratte, o artificiali, appunto.
Non mancano vari spunti di riflessione: le palme sulla spiaggia di uno stabilimento fuori dal loro habitat; legno d'abete, e legno esotico dell’Amazzonia per costruire la passerella ciclopedonale per il nuovo Parco marittimo di Ravenna (definito “green”); gli alberi del Bosco Verticale di Milano costretti in vasche perimetrali; l’ecomostro sulle alture del Prà di Genova, detto “Le Lavatrici”, ispirato al movimento metabolista giapponese che vedeva nello sviluppo tecnologico e nella crescita metropolitana un’evoluzione naturale del potere vitale dell’uomo.
Nella seconda sezione si documenta l’antropizzazione estrema dell’ecosistema costiero prendendo come esempi paradigmatici le navi da crociera del progetto Home Port, e dall’altra parte le navi fluviali abbandonate a Ravenna, e ancora non una fabbrica qualsiasi ma la fabbrica Solvay che ha trasformato il litorale di Rosignano, in Toscana. Lo sversamento di sostanze tossico nocive in ambiente marino ben rappresenta l’approccio barbaro all’ecosistema, trattato come un materiale passivo ed informe, un sostrato inanimato, una risorsa da sfruttare, e manipolare, una vera e propria macchina al servizio dell’uomo anziché un organismo vivo, “bios”, essenza viva e organica che ci comprende e ci compenetra, e da cui siamo interdipendenti e non separati in una rigidità dualistica.
È in questo senso che le sequenze di foto (già dalla prima sezione) mostrano spesso cartelli di divieto, alle volte giustamente motivati da emergenze sanitarie, che però sono causate proprio da inquinamenti indotti da attività umane, come per il divieto di balneazione nell'area costiera attigua al Fosso Bianco di Rosignano Solvay, ovvero il canale di scarico in mare, oggi prolungato fino alla battigia, della fabbrica-sodiera; altre volte invece, come avviene per il cartello dello stabilimento balneare di Rosolina, per trasmettere quest’ansia di controllo da parte dell’uomo degli spazi naturali ed assieme dell’uomo stesso, che poi non è separato o scisso, ma è un animale come tutti gli altri.
Un animale non in armonia con la propria natura.
Ed avviene così che al posto delle tracce di uomini ed animali si sostituiscano tracce altre, come quelle delle insegne delle grandi multinazionali, come quelle del cane dell'Eni, veri giganti che dominano quest'Era, l'Olocene, come i dinosauri dominarono a loro tempo il Giurassico.
Ed è da questo “ordine” traballante, da questo assetto incerto che prende forma la terza sezione che descrive invece il “caos incontrollato” della natura, di come poi l’ha sempre individuata una cultura prettamente antropocentrica ed iper umanista, col suo bisogno appunto di indirizzarla, contenerla, reprimerla. Mentre all’antropizzazione dell’esistente non si dà mai un freno. E così all’urbanizzazione coatta, all’industrializzazione, alla speculazione finanziaria, alle “esigenze” del mercato.
Sono immagini che raccontano l’alluvione di metà maggio 2023, e le giornate dopo il ritiro delle acque, quando non rimanevano che fango e accumuli, cataste di oggetti, macerie. Sono ambientate nei comuni romagnoli di Conselice, Sant’Agata sul Santerno, Boncellino di Bagnacavallo e Forlì. Il racconto si sussegue coi mezzi dei vigili del fuoco che attraversavano le vie dei comuni colpiti dall'alluvione, e poi con gli “angeli del fango” che tornano a casa dopo una giornata a spalare; sono rappresentati oggetti emblema di quest’evento drammatico, e poi il fango, tanto fango che raggiungeva ogni cosa.
Si apre infine la quarta parte, che esplora tutte le contraddizioni e le dissonanze del nostro vivere civile, la nostra "civitas" appunto, che si vuole così rigidamente divisa e separata da natura, fenomeni naturali e ambiente selvaggio.
Si svelano quindi immagini del paesaggio urbano, della metropoli e delle sue trasformazioni, dell’urbanizzazione sfrenata, che pongono sempre più barriere in fatto di diseguaglianze sociali, creando continui distanziamenti e separazioni tra varie classi di umanità.
Vi è lo sguardo su una Milano ricca tanto di grattacieli dalle altezze formidabili quanto del bisogno impellente di eliminare le innumerevoli disparità e le diseguaglianze poste proprio dal modello capitalista e dal razzismo, come bene denuncia il murale di Rosk. Il grattacielo della Regione Lombardia incombe sul piccolo edificio dipinto dove sono rappresentati due bimbi intenti a spingere muri per ridurre la distanza che li divide. In primo piano due alberi, presenze spesso inascoltate, fanno da cornice e si aprono come un sipario sulla scena. Quelle stesse distanze incentrate sui divari dati dalle innumerevoli sperequazioni sociali, sono i protagonisti delle altre sequenze di immagini sulla città di Bologna e i suoi “rimossi”. Come recita il titolo della sezione, si esplora qui proprio la "civitas" nella sua accezione propria di cittadinanza. Così ci appaiono Palazzo Bonaccorso, sede secondaria degli uffici comunali e piazza Liber Paradisus ai suoi piedi, la cui toponomastica celebra il testo di legge di abolizione della schiavitù in epoca Medioevale, e di estensione della cittadinanza, affiancati da un cartello di divieto con scritto “proprietà privata”, e subito dopo un mendicante e un angolo di un luogo abbandonato, che insieme vogliono rappresentare i nuovi “non liberi”, a dispetto del nome della piazza di cui sopra, “simbolo” di liberazione e del primato di Bologna come prima città che abolì la servitù della gleba. A significare che forse non ci si è liberati mai davvero completamente della schiavitù, e che l'ordine arbitrario a cui anche noi stessi come comunità sociale e politica siamo sottoposti, ci opprime creando differenze ed esclusioni, vere e proprie gerarchie sociali, negandoci qualcosa di così naturale e connaturato con la nostra stessa essenza di essere umani, come la libertà! La foto finale rappresenta Piazza Dalla con un divieto d’accesso a significare come non si riescano a realizzare interazioni e luoghi di scambio, perché il profitto privato ha sostituito l’interesse pubblico, il bene di tutti, la tutela delle categorie più vulnerabili, e simboleggia che il modello di una città inclusiva è ormai al tramonto. Significa anche che è andato perso il governo pubblico sul territorio, l’urbanistica pubblica, democratica, il potere dei cittadini sulle scelte di edilizia. Lucio Dalla, rappresentato in una foto di Luigi Ghirri, cantava “Attenti al lupo” contro la morale borghese e solidarizzava con i senzatetto in “Piazza Grande”, quindi è incoerente la trasformazione che sta subendo la Bolognina, ove Piazza Dalla è sita, con la filosofia e i valori del celebre cantautore. In poche parole, ormai la "piazza", con tutti i valori sociali e culturali che si porta dietro da secoli, con i riferimenti alla democrazia, al dibattito pubblico, al confronto, sembra ci sia stata proprio negata!
Biografia:
Federica Chiarentini, nata a Rovigo, vive a Lugo di Romagna (RA). Ha frequentato corsi presso Spazio Labo’ a Bologna sia di fotografia digitale che analogica. Iscritta all’A.I.F., ha pubblicato fotografie per giornali locali, gestisce un sito personale dove pubblica prevalentemente foto di luoghi abbandonati, eventi quali manifestazioni sportive e politiche, paesaggi sia naturali che urbani. Una sua foto è stata pubblicata nella rivista di architettura Platform.
Coltiva questa passione da molti anni e collabora con Sara Silvestrini in camera oscura. Coniuga alla passione per la fotografia quella per la parola pubblicando varie sillogi poetiche.