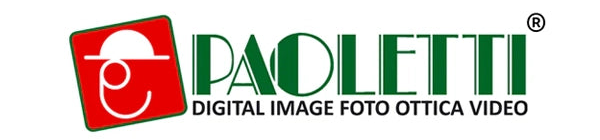Questo progetto fotografico si pone l'intento di mostrare il contrasto fra paesaggi che paiono alla nostra percezione surreali, ovvero ai limiti della realtà o perlomeno dell'oggettività, sospesi in un universo che pare quasi onirico, e paesaggi invece contaminati dallo scandimento ossessivo e rituale di linee e segmenti geometrici equidistanti o ancora da figure geometriche ben definite. Quale dei due paesaggi è davvero astratto e quale è invece più simile alla realtà, o meglio, alla nostra maniera di percepirla? Quali trabocchetti escogita la nostra mente per organizzare il pensiero e gestire l'esistenza e tutto ciò che vediamo, sentiamo, avvertiamo mediante i sensi? Quale è il confine fra realtà ed astrazione? Quale il punto di contatto fra entità e ogni sua seppur imperfetta rappresentazione?
Figure o linee geometriche ben definite, dai contorni nitidi e ben determinati, forme perfettamente bilanciate tra loro nella distanza e nella lunghezza sempre conforme, quasi rituale, oppure linee e punti sfocati, paesaggi sospesi fra cielo e terra, contorni, confini sbiaditi o addirittura inesistenti, trasfigurati quasi in un'altra dimensione, forse proprio nel sogno, nella confusione onirica, quasi metafisica: quali sono fra di essi i più concreti, i più veri, i più tangibili? Infine, dove finisce la realtà stessa quando si tramuta in un immaginario astratto senza volumi né consistenze, in un'immaterialità quasi trascendentale? L'astrazione vera è un paesaggio quasi fiabesco, surreale, un contorno non nitido, una linea sfocata, un'immagine fotografica che appare sgranata, sbilanciata, o non è piuttosto il nostro modo di organizzare e gestire il pensiero, dunque poi il pensare la realtà, ad essere astratto e forse approssimativo, a chiudere questa stessa realtà, o la presunzione che abbiamo di essa, a circuirla e circondarla entro mura stringenti, costruirla o costringerla in spazi stretti, linee rigide, geometrie forzate benché armoniche e talvolta affascinanti, ossessive e talvolta maniacali, quasi ipnotiche infine?
E avviene anche che linee e forme abituali, ordinarie, tipiche del nostro comune quotidiano assumono, se prese da una prospettiva diversa, inedita, inusuale, un significato nuovo, originale, ma forse mediato dal nostro universo subcosciente, dall'inconscio primordiale e collettivo. Ed è così che due fari su una spiaggia deserta possono apparire come due creature aliene, intrusi in un paesaggio che diventa a sua volta straniante. Ed ancora si susseguono innumerevoli i simboli, come le corolle aperte d'un fiore che circondano il pistillo, che ricordano vagamente le sopracciglia attorno la pupilla di un occhio. Oppure, un gioco di luce dentro la cupola di una discoteca abbandonata, che assume la forma di un cuore, inserendosi nel graffito di street art presente e dialogando con esso.
Ed ancora altre forme e figure si dipanano da questa narrazione per mostrarci tramite delle messe in posa, qualcosa di più sugli enigmi della rappresentazione umana, densa di profondi significati simbolici e di molteplici possibili interpretazioni che ruotano attorno a determinati codici linguistici derivanti a loro volta da una certa storia antropologica, sociale e culturale. Il fulcro di queste rappresentazioni umane è il concetto di “maschera”, al limite tra realtà e finzione, tra ciò che siamo veramente e come invece vogliamo apparire. Ma anche di ciò che vogliamo nascondere, velare, o rendere ambiguo. Un volto coperto, una testa girata verso la parete, un occhio che non vede e non si fa vedere, celato dietro al fumo. Come potremo mai vedere e catturare la realtà?